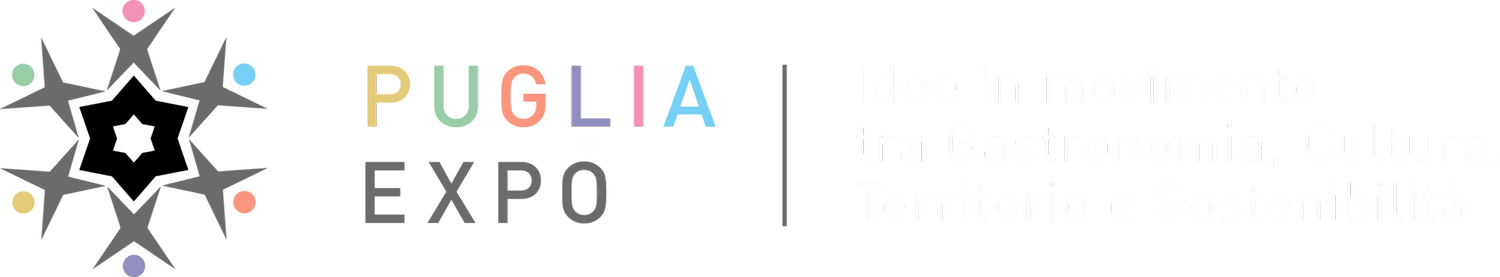Il filosofo francese Michel de Montaigne amava raccomandare agli educatori e ai precettori dell’epoca, quanto fosse “meglio una testa ben fatta che una testa ben piena”. Ripensando, oggi, a questa lungimirante intuizione mi appaiono ancor più illuminanti le parole che, in merito a questa formulazione, ebbe a scrivere in un suo libro, La tête bien faite, Edgar Morin. Cosa significhi una “testa ben piena” dovrebbe ormai essere chiaro a molti, non solo riferito al nostro contesto, ma, mi si consenta il beneficio del dubbio, ritengo che non guasti chiedere un aiuto alle autorevoli delucidazioni di Morin. “Una testa ben piena”, infatti, egli scrive, “è una testa nella quale il sapere è accumulato, ammucchiato, e non dispone di un principio di selezione e di organizzazione che gli dia senso”. “Una testa ben fatta”, al contrario, “significa che invece di acccumulare il sapere è molto più importante disporre allo stesso tempo di un’attitudine generale a porre e a trattare i problemi, di principi organizzatori che permettano di collegare i saperi e di dar loro un senso”. Questa premessa, rubata ad uno dei pensatori che ogni giorno continua a stupirmi per la freschezza delle sue idee, altro non è che la spiegazione colta del mio incontro con il mondo dell’economia, del risparmio e dei mercati finanziari, nonché del mio rapporto di collaborazione con Swiss & Global Asset Management che, come avrebbe di sicuro pensato la “buon anima” di mio padre, con il sottoscritto non si comprende “che c’azzecchi”. Ma il mondo sta cambiando, per fortuna, e con esso anche i paradigmi generali con i quali dovremmo imparare meglio e più saggiamente ad interpretarlo. “Le teste ben piene” così come le “economie ben piene”, per non parlare dei “consumi esagerati” o dello “spreco del cibo”, dei “suoli ben pieni” o delle “pance ben piene”, rappresentano dei concetti di vita, dei valori comportamentali che non solo non funzionano più, ma che si presentano come desueti, come incapaci di convivere e d’interagire con l’attualità. Così, vuoi perché ho la presunzione di saper connettere le cose tra loro e vuoi perché ho abbracciato da tempo il cosiddetto design thinking, che altro non è che il saper disegnare con spirito pragmatico e visionario le idee, ho cominciato ad intuire che esistono analogie forti tra il funzionamento dei processi del mondo dell’agricoltura, del cibo e del vino, e l’evolversi dei mercati economici e finanziari.
Certo, la mia formazione culturale, la speranza di avere, forse, una “testa ben fatta”, mi portano a pensare a un’“economia dell’abbastanza”, ma non della decrescita, collegata a un’idea di denaro, per “fare denaro” che, come dice Woody Tasch, presidente dell’Investors’ Circle e fondatore di Slow Money, deve però indirizzarsi “verso la vita, verso imprese che accrescano la qualità della vita, che tutelano e ripristinano la fertilità, la biodiversità e la salute delle bioregioni, delle famiglie e delle comunità che in esse vivono”. Un uso del capitale d’investimento, dunque, come antidoto e come superamento della malattia della quantificazione eccessiva, del “ben pieno”, dell’“accumulato e dell’ammucchiato”, senza “un principio di selezione e di organizzazione che gli dia un senso”, che lo riporti, per alcuni aspetti, a una sorta di “omeopatia finanziaria”. E, se è vero come è vero, quello che puntualmente scrive in un editoriale Carlo Benetti (L’Alpha e il beta 27.10.2014), e cioè che proprio “nelle mappe della nuova geografia economica acquisiranno via via maggior importanza le realtà ancora marginali degli investimenti ad impatto sociale o nelle “abilità profonde” del capitale umano e civile”, è altrettanto probabile e auspicabile che tutto questo si verifichi sempre di più nell’ambito della produzione del cibo e delle realtà agricole e contadine. Io sono convinto di tutto questo e, non a caso, sono portato a credere con ottimismo al fatto che, oggi, sia appunto il cibo e il processo della sua realizzazione a generare una positiva riflessione che permetterà di capire meglio il presente, per progettare adeguatamente il futuro. Il cibo, se ci pensiamo, è un po’ come una rete, come un network complesso, come un sensore globale e locale; guardando tra le sue pieghe è possibile percepire e leggere il futuro, trarre degli insegnamenti multidisciplinari, acquisire modelli da replicare in altri settori. “Mangiare è un atto agricolo”, una case history universale, un condensato di discipline e di visioni, una cerniera tra natura e cultura, tra economia e politica. Ci vuole pazienza per capire tutto questo e, del resto, come diceva Confucio, la pazienza rende felici. Qualcuno aggiunge che dà pure speranza.
Tratto dalla Rubrica FILL THE GAP di Swiss & Global Asset Management Italia
A cura di Giacomo Mojoli